BATďSI
(plurale) (maschile) = "Monelli"
Termine non pi¨ in uso che identificava nella seconda
metÓ dell'800 i ragazzi che oggi chiameremmo "ragazzi di strada" , anche se
allora il significato era decisamente letterale in quanto erano quasi sempre
ragazzi senza famiglia e senza casa che sopravvivevano di espedienti, non
sempre legali.
|
 |
|
Fontana in piazza Marsala, Genova
1880 c.a.
Tra i ragazzi ben vestiti alcuni poveri, certamente "bat˘si".
(Foto di A.Noack - Archivio Fotografico del Comune di Genova) |
Il nostro"Bat˘so"
genovese non vanta la notorietÓ che Victor HUGO ha assegnato a
"Gavrosche" e neppure quella data da Ferenc MOLNAR ai suoi
"Ragazzi della via Pal". Ed anche gli
"Scugnizzi" napoletani, per merito di scrittori e registi di cinema,
godono decisamente di maggior fama.
Storicamente l'ACCINELLI (1776), il
CELESIA (1855) e il
VITALE (1947) citano nei loro scritti che i veri protagonisti della
rivoluzione di Genova del 1746 furono due "Bat˘si":
Balilla, che come disse MAMELI "gitt˛ il ciotolo incantato", e
Pittamuli,
che appicc˛ il fuoco alla caserma degli Austriaci che era sul fiume Bisagno
presso il ponte di Sant'Agata, nota localitÓ della Genova antica.
Ma oltre ai due pi¨ noti, moltissimi erano i ragazzi
anonimi che sopravvivevano miseramente e a volte manifestavano la loro
triste sorte, come quelli che al grido di "Abbasso il lusso" lanciarono
sassi alle signore ingioiellate che, sulle portantine, nel 1849 si facevano
portare al Teatro Carlo Felice nel centro della cittÓ.
La loro
non era invero una lotta di classe o una lotta politica, ma era semplicemente
una manifestazione dell'enorme disagio in cui vivevano quotidianamente.
Molto indicativa fu la descrizione di questi ragazzi
fatta da un noto quotidiano genovese alla metÓ dell'800:
|
"Viso sudicio, mani nere. Il sudiciume Ŕ
la sua prima camicia. I suoi capelli non conoscono altro
pettine che le cinque dita della mano. I suoi pantaloni
sono crivellati da ampie feritoie che lasciano passare la luce anche
dove l'ombra sarebbe di rigore. Ordinariamente porta i
piedi scalzi che gli permettono di misurare la profonditÓ delle
pozzanghere. Da sette anni in poi canta, fischia, gioca,
prende parte alle dimostrazioni politiche, alle riviste militare, agli
spettacoli pubblici. E' il Paganini del turpiloquio. Quando alla mattina esce di casa ( se ne ha una), ha un solo
programma: far venire sera evitando il passaggio delle carrozze ed il
lavoro. Non ha opinioni politiche, ma preferisce le
dimostrazioni dove si grida < abbasso!>. Dinnanzi alla
vetrine di un Restaurant, sputa. E' la protesta della
fame. Il muro Ŕ il suo diario, la sua lavagna; lÓ scrive
le sue memorie. Maneggia i sassi con gran precisione,
soprattutto contro le insegne". |
Lo sfondo che circondava una simile vita era, a volte, di pura
sopravvivenza.
Giuseppe VERDI, a Genova per la presentazione di
una sua opera nel
1891, vedendo mendicanti (e tra loro anche ragazzi) dormire per la strada
sul selciato sotto i portici
dell'Accademia, presso il Teatro Carlo Felice nel centro di Genova, resta
colpito dal
"miserando spettacolo che offrono i mendicanti che, con un
freddo siberiano, dormono sul selciato", ed inizia una sottoscrizione per la
costruzione di un dormitorio pubblico, sottoscrizione a cui parteciperanno
anche molti altri benefattori.
|
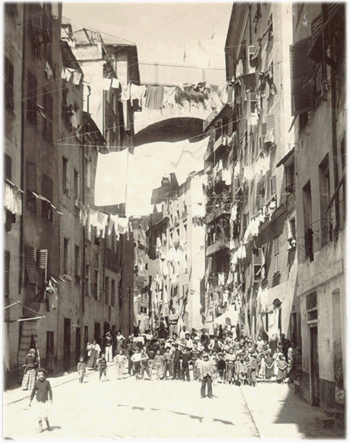 |
|
Via Madre di Dio, Genova 1880 c.a.
Anche in questa foto i ragazzi sono numerosi
(Foto di G. Sciutto - Archivio Fotografico del Comune di Genova) |
Anche Nicol˛ GARAVENTA, come
primo impegno, per aiutare questi ragazzi abbandonati a se stessi, si
interess˛ per trovare un locale chiuso dove questi piccoli infelici
potessero trovare almeno un modesto ma sicuro giaciglio nelle fredde notti,
e successivamente, su sua iniziativa nel
1885, ottiene
la concessione ad ospitare in modo continuativo sulla Nave Scuola (Brigantino
Daino che
in seguito prenderÓ poi il suo nome) un certo numero di questi ragazzi
"bat˘si",
per aiutarli ed insegnare loro un primo mestiere: il marinaio, per poter
sopravvivere. Altri, meno fortunati, quando erano
presi dai gendarmi erano mandati al carcere minorile
"Generale" di Torino,
dove la vita e i metodi educativi erano decisamente molto duri e severi.
Aiuti vennero anche dalla Chiesa che con:
don Francesco MONTEBRUNO,
don
Eugenio FASSICOMO, e l'istituto dei
Salesiani di Sampierdarena cercavano di
aiutare questi ragazzi abbandonati avviandoli ad un onesto lavoro inserito
nella societÓ dell'epoca, che nel campo della solidarietÓ era ancora
decisamente agli inizi.
Anche fuori dal centro storico, ad esempio nella zona
di Porta Pila, vi era una
"Corte dei miracoli" molto eterogenea composta da:
accattoni che espongono le proprie deformitÓ, donne scarmigliate che con
urla strazianti cercano di attirare l'attenzione e l'elemosina dei passanti,
fanciulli e ragazzini che in mezzo ai banchi del locale mercatino (con le
lacrime agli occhi) dovevano impietosire e stimolare la regalia di pochi
spiccioli che poi venivano presi dai loschi individui che li costringevano
con le botte a quella sceneggiata.
|
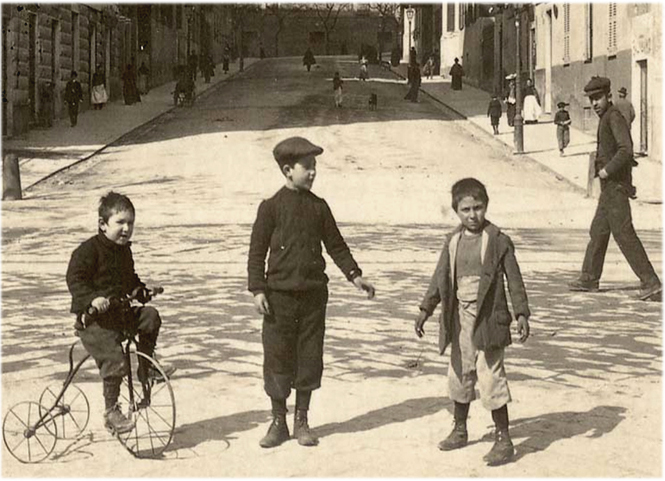 |
|
Questi tre ragazzi fotografati a
Genova in
via Nino Bixio alla fine dell'800 sono decisamente diversi.
I due di sinistra, bene in carne, sono ben vestiti e con il triciclo,
mentre il ragazzo di destra, a giudicare dalle guance quasi incavate,
dai vestiti gualciti e trasandati e dalle mani sporche potrebbe essere
l'emblema del "Bat˘so" di strada.
|
Quando nel
1880 viene aperta ed inaugurata la centrale
ed elegantissima via Roma, i giornali dell'epoca dopo la descrizione dei
marmi e dei cristalli splendenti, ricordano anche le nenie dei suonatori di
organetto, gli strilli dei venditori di cerini, i lamenti dei
mendicanti che stazionavano nelle vicinanze.
E i genitori di questi infelici ragazzi? Se
esistevano, molto spesso se ne disinteressavano o alle volte addirittura
arrivavano, per recuperare del denaro, a
"venderli" a personaggi senza
scrupoli che li portavano in altre cittÓ costringendoli all'accattonaggio.
|
 |
|
Ecco lo "Scuolabus" che raccoglieva
i ragazzi dai paesini vicini
per portarli a scuola. - Genova fine '800.
(Foto della Collezione S.Finauri)
|
E la scuola pubblica? Come riporta un
giornale del settembre
1884, nelle aule spesso anguste erano stipate classi
di ottanta alunni, cinque per banco. E chi aveva i vestiti
troppo strappati e laceri o era senza scarpe non veniva neppure ammesso in
scuola.
E' quindi ovvio che superata l'etÓ della fanciullezza
ed avvicinandosi l'adolescenza, senza genitori, senza scuola, senza
controllo, questi
"batosi" si organizzassero in gruppi autonomi o bande che
con varie tecniche distrattive rubavano la merce esposta dai banchi dei
mercatini o dei negozi sia per mangiare che per rivenderla, o addirittura
imponevano ai bottegai dei contributi per non essere da loro infastiditi.
Molto spesso i punti di ritrovo di queste "compagnie" erano le calate del
porto dove potevano trovare nelle chiatte o sui moli un riparo e un
giaciglio sui sacchi di grano o di caffŔ che erano lý ammonticchiati.
A
volte, come viene citato dalla
"Gazzetta di Genova"
del
10 luglio 1860, vi
erano frequenti scontri fra opposte bande (forse per il controllo dei propri
territori) a suon di sassaiole sul greto del torrente Bisagno spesso con
feriti gravi o con esiti fatali, come avvenne nel
1868 quando sul Bisagno,
provenienti da Borgo Incrociati, giunsero sui ragazzi
"duellanti" dei colpi
di fucile da caccia che ne impallinarono alcuni, ferendoli anche gravemente.
Altre
"battaglie" note sono nel
1877 in piazza San Lorenzo con i ciottoli
della strada, nel
1878 presso Ponte Pila, nel
1879 sul Pian della
Rocca(corso Dogali), nel
1881 sulle mura di San Bartolomeo.
L'arma preferita era il
"cacciafrusto" che non era la classica fionda, ma
una sua versione adattata funzionalmente.
|
![]()