|
IL LIBRO:

|
L' Argomento
Storia - architettura - Mappe - Fasi
della costruzione
Descrizione del percorso con itinerari storico-naturalistici
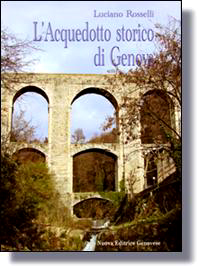 Fin dai tempi antichi lo sviluppo della città di Genova è stato legato
all'acqua, elemento prezioso quanto necessario.
Fin dai tempi antichi lo sviluppo della città di Genova è stato legato
all'acqua, elemento prezioso quanto necessario.
Le sorgenti cittadine e le cisterne per la raccolta
delle acque piovane erano sparse capillarmente in tutta la città, ma
difettavano per portata e continuità di flusso a tal punto da non riuscire
a garantire ai Genovesi il fabbisogno giornaliero, specialmente nei
periodi di siccità. Fenomeno questo ricordato
anche dal Giustiniani (1470-1536) nei suoi Annali della Repubblica di
Genova, dove viene citata la straordinaria siccità del 1428, nel
corso della quale inaridirono le tre maggiori fontane di Genova: le "Fontane
Marose", il "Rivo Torbido" e le "Pozzarre".
Il primo acquedotto genovese, di cui abbiamo
testimonianza, è quello romano risalente al 200 a.C.
La sua origine è incerta, e i pochi dati a nostra disposizione vogliono
che questo primo acquedotto venisse edificato dopo la distruzione di
Genova da parte dei Cartaginesi e che, poco dopo, Roma inviasse il Pretore
Spurio Lucrezio con due legioni ed un numero considerevole di schiavi per
ricostruire la città, dotandola anche di un acquedotto "moderno",
che venne alimentato dal torrente Feritore. La
presa di questo acquedotto era localizzata alle rapide del Montanasco, nei
pressi del Follo , zona ricca di acqua per la presenza del rio
Coverciano (che confluiva nel Bisagno proprio nelle vicinanze della
presa), e - poco più a monte - del Lacus Draconarius.
I fattori importanti che contribuirono a prediligere la
valle del Bisagno furono certamente due: la relativa vicinanza alla città
e la maggiore disponibilità idrica dovuta ad una più intensa piovosità
rispetto alle alte valli liguri.
Il tracciato di questo acquedotto, che è stato
calcolato intorno agli 11 km, con una pendenza media di 3,3 metri per km,
si sviluppava sulla sponda destra del Bisagno ed era situato ad un livello
più basso rispetto all'acquedotto medioevale. Esso
portava l'acqua in città passando per Montesano dietro l'ex convento delle
Fieschine, a monte della stazione Brignole, proseguendo verso l'attuale
Villetta Di Negro per poi scendere a Piccapietra e superare la collina di
S.Andrea a circa 30 metri di altezza sul livello del mare, necessaria per
raggiungere tutte le aree della città di allora, che si estendeva tra il
colle di Sarzano e la Ripa.
Tracce di questo manufatto romano sono ancora visibili
in via delle Ginestre e all'interno del cimitero di Staglieno.
Anche in città furono trovate vestigia dell'acquedotto,
durante la demolizione del convento di Sant'Andrea nel 1904, infatti
l'architetto spagnolo Alfredo D'Andrade (1839-1915), addetto ai lavori, ne
rinvenne un tratto che successivamente fu demolito.
Luciano
Rosselli
|
![]()