|
|
I SANTUARI DELLA DIOCESI DI GENOVA
Santuario N.S. dell' ACQUASANTA
di
Luciano dr. VENZANO
Accademico Esperto Campo Scienze Storiche
(Accademia Archeologica Italiana)
LA STORIA MODERNA
(RITORNA)
![]() on il decreto regio che porta la data del
13 settembre 1824 e 3 aprile 1833 si
riattivava così la potenzialità dell’Opera, si provvedeva alla progettazione e
costruzione dei bagni pubblici che permettessero l’utilizzazione, a beneficio di
tutti, dell’acqua solforosa che sgorga ai piedi della Cappelletta.
on il decreto regio che porta la data del
13 settembre 1824 e 3 aprile 1833 si
riattivava così la potenzialità dell’Opera, si provvedeva alla progettazione e
costruzione dei bagni pubblici che permettessero l’utilizzazione, a beneficio di
tutti, dell’acqua solforosa che sgorga ai piedi della Cappelletta.
Si costruì pertanto lo stabilimento termale, decidendo di chiedere al Segretario
di Stato una nuova concessione che venne fatta dal re Carlo Alberto con decreto
in data 3 aprile 1833. La Protettoria non trascurava gli ampliamenti necessari,
portando a termine nel 1845 il nuovo braccio, che forma l’ala destra del
santuario.
Una nuova situazione venne a determinarsi a partire dal
settembre 1961. Raggiunto l’accordo tra la Curia arcivescovile genovese e l’Opera Pia, il
santuario veniva restituito completamente all’autorità dell’arcivescovo, con
piena proprietà ed autonomia amministrativa. L’Opera Pia rimane, con il suo
statuto che prevede, come scopi principali dell’Ente stesso, il buon
funzionamento dei Bagni e l’offerta di locali adatti ad accogliere la scuola
elementare di Stato, per i ragazzi della zona.
La strada di accesso al santuario era, nei secoli scorsi, impervia e faticosa. Si trattava di risalire il torrente Leira da Voltri, passando per Crovi e
Fondocrosa, con un sentiero disagevole. C’erano da superare colline e foreste.
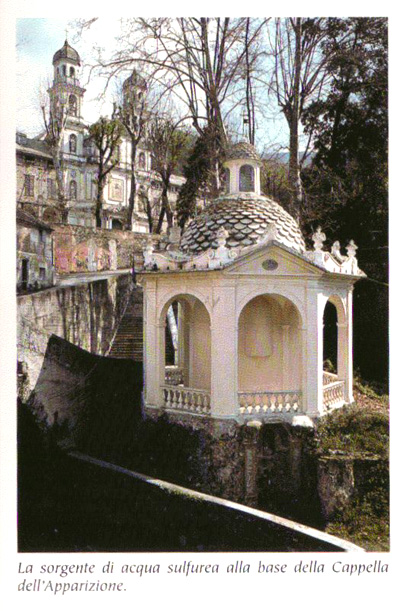
Nel 1640 ebbero inizio i primi lavori, per giungere con una strada sino ai
confini della parrocchia di s. Ambrogio di Voltri. L’impresa fu poi proseguita
nel 1665 dalla parrocchia di Mele, non senza qualche contrasto per gli
acquedotti che rifornivano le cartiere per mezzo d’un ponte (Porrata dal nome
del costruttore), che tutt’ora esiste. Detta strada fu ampliata nel
1715, e finalmente nel 1787 perfezionata e resa del
tutto carrozzabile sino alla Piazza del Santuario.
Anche la strada venne posta,
nel 1788 sotto la protezione del Senato. Resa interamente carreggiabile nel
1797. L’intero percorso venne ulteriormente migliorato, in alcuni tratti, per le nozze
regali celebrate al santuario il 21 novembre 1832, fra Ferdinando II, re di
Napoli e Maria Cristina di Savoia.
Prima di giungere al santuario, il pellegrino
incontra più a valle un’artistica cappella, che accoglie l’antica immagine
lignea della Vergine.
Le due statue, della Madonna e del Bambino, poste nella cappelletta furono incoronate nel
1890 da mons. Salvatore Magnasco arcivescovo
di Genova. Sono due costruzioni caratteristiche ed entrambe ben conservate.
La
“cappelletta” sorge sul punto preciso dove sgorga la polla generosa di acqua
sulfurea. Costruita nel 1769 con agili arcate fiancheggianti ed una cupola
semisferica.
Mentre nella seconda metà del sec. XVII fervevano i lavori
all’interno del santuario, si decise la costruzione dell’attuale cappella.
All’interno la cappella si presenta decorata di marmi, stucchi ed affreschi
eseguiti dal pittore Giuseppe Paganelli. Vi si trovano due tele ad olio dipinte
dal voltrese Giuseppe Canepa, raffiguranti due prodigi attribuiti
all’intercessione della Vergine.
Nel 1750, per iniziativa del sac. Piccardo
Francesco sorse, a monte della cappelletta, la Scala Santa in cima alla quale
spicca la statua dell’ "ECCE HOMO ".
E’ noto che la Scala Santa è una riproduzione di quella salita da
Gesù a
Gerusalemme nel palazzo di Pilato, fatta smontare e quindi trasferire a Roma da
sant’Elena, madre dell’imperatore Costantino.
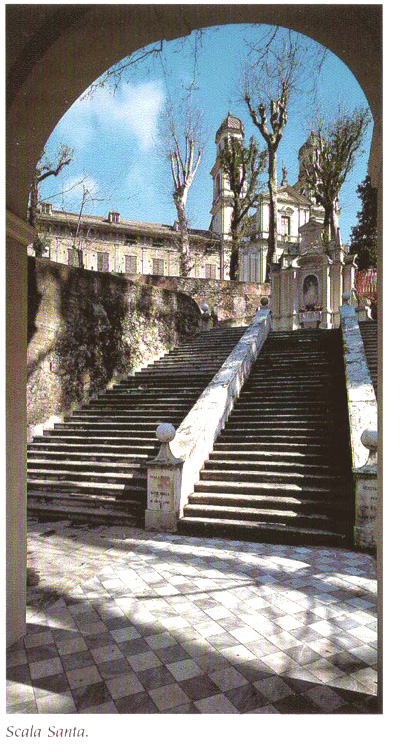
La scalinata, che recentemente è stata restaurata, viene tuttora risalita dai
confratelli con i “Cristi” in "CROCCO"
e dalla cassa della Madonna. Oggi, come secoli fa, i fedeli accorsi in
pellegrinaggio al santuario seguono la fatica dei “cristezanti”.
Nel corso dei secoli la pietà dei fedeli ha fatto affluire al santuario non
pochi oggetti preziosi, testimonianza di fede e di gratitudine.
Purtroppo le
vicende storiche, non sempre propizie, hanno impedito che giungessero tutti sino
ai nostri giorni. Alcuni sono stati sottratti o alienati. Si ricorda che già nel
1671, nel corso d’un pellegrinaggio, la Confraternita
dell’Assunta di Pra’ portò alla Vergine due corone d’argento. Da s. Ambrogio di Voltri portarono una collana d’oro.
Altre Confraternite
offrirono per l’occasione un calice ed una lampada d’argento, varie argenterie,
paramenti di pregio, tovaglie, camici e pizzi. Gli oggetti di maggior valore sono il bel trono d’argento del sec.
XVIII, che la
rivoluzione del 1798 aveva sottratto, ma che fu poi riscattato da un
benefattore. Si conservano due corone d’argento per la statua della cappelletta
ed altre due per quella dell’altar maggiore, di stile barocco e veneziano.
Altri oggetti di pregio ancora esistenti sono: tre pissidi, un “servizio” di
carteglorie, due calici d’argento ed un reliquiario.
Nel 1832 il tesoro s’arricchì d’uno splendido ostensorio, di stile impero, dono
di Maria Cristina di Savoia e di Ferdinando II di Borbone. E’ d’argento dorato,
con rapporti in oro. La sfera è sostenuta da un angelo dalle ali spiegate,
mentre alla base sono collocati i simboli dei quattro Evangelisti, intervallati
da pietre preziose.
In occasione dello storico matrimonio, venne pure donata da
parte di alti funzionari di corte, una preziosa collana con topazi ed ametistea. Vi si possono infine ammirare le due auree corone, poste in capo alla Vergine e
al Bambino, dall’arcivescovo di Genova, mons. Salvatore Magnasco il 27 luglio
1890, giorno solenne dell’incoronazione, compiuta per decreto Vaticano.
Il santuario come si vede adesso fu consacrato dal beato mons.
Tommaso Reggio il
10 luglio 1894.
Il concerto delle campane, donate dal signor
Ferrari
Sebastiano di Pra’, fu benedetto da mons. Edoardo Pulciano nel 1907 e posto sul
campanile di levante, mentre in quello a ponente permangono quelle antiche.
Durante il secondo conflitto mondiale dopo l’8 settembre i tedeschi installarono
un loro contingente nello stabilimento bagni.
![]()
![]()
![]()